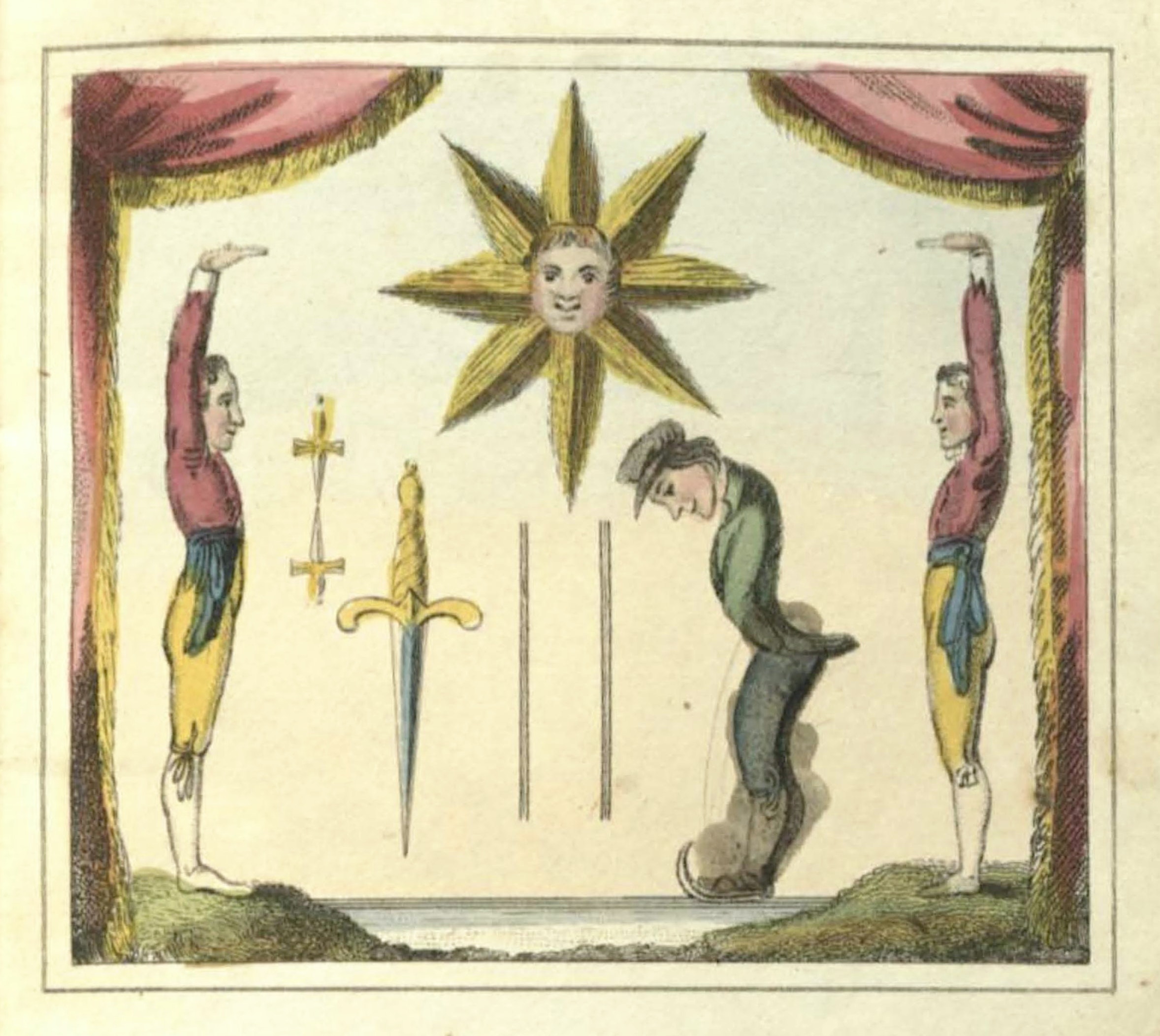Se ottenere l’indipendenza vuol dire l’assunzione da parte delle élites locali, magari con prosopopea populista su lingua e tradizioni, di un potere politico saldamente legato all’economia, alla finanza e alle logiche di sviluppo del capitalismo mondiale, non riusciamo a capire che interesse potrebbe avere la massa dei cittadini oggi in costante difficoltà – che comprende proletari e sottoproletari, ma anche piccoli e medi agricoltori, artigiani e imprenditori che non riescono più a reggere la concorrenza del mercato globale – ad aderire a un cambiamento nominale che non muterebbe sostanzialmente la loro condizione di precarietà e di progressiva perdita di garanzie sociali. “Franza o Spagna purché se magna” diceva il Guicciardini nell’epoca in cui l’Italia era terra di conquista. Ma questo suo pragmatismo nel cambiare alleanze aveva come fine politico quello di salvaguardare le Signorie italiane e in particolare la sua Firenze.
Pour un nouveau modèle de développement
L’indipendenza oggi, per avere un senso concretamente comunitario e identitario, deve essere in grado di proporre un nuovo modello di sviluppo che, partendo dalle peculiarità storiche locali, elabori un piano politico-sociale che rimetta al centro della vita di un paese l’uomo e non il mercato, con un percorso di controtendenza rispetto al delirio consumistico del commercio globale. E il presupposto indispensabile per fare questo è il recupero di quei saperi millenari che hanno plasmato nei secoli comunità e territori, producendo qualità piuttosto che quantità, relazione anziché alienazione. Occorre, dunque, mettere in moto processi di decrescita solidale che tendano a ricostituire pezzi di comunità e a rivalutare socialmente attività dei settori primario e secondario che la produzione industriale prima e il commercio globale poi hanno pressoché cancellato. Ma è proprio il valore “lavoro” che deve essere ripensato in modo antitetico alla logica dell’industrialismo: non più una coazione - oltretutto oggi anche meno tutelata, ma paradossalmente un privilegio di pochi rispetto al sempre più vasto “esercito di riserva” della manodopera - ma un ruolo operativo condiviso e riconosciuto, socialmente ed economicamente, che consenta a tutti di sentirsi parte integrante di una comunità di valori e di intenti.
Les trois conditions du véritable changement
È questo un percorso che necessita di scelte drastiche, etiche e solidali, basate essenzialmente sul concetto di “bene comune”, inteso concretamente giorno per giorno e non soltanto come un obiettivo di tendenza, che, secondo noi, per consolidarsi come interazione sociale imprescindibile deve adottare strategie inclusive in tre aspetti essenziali della vita di una comunità che voglia essere davvero libera e indipendente:
- il recupero dell’agricoltura e dell’artigianato tradizionali, depositari dei valori storico-arcaici della nostra civiltà;
- la trasformazione dell’Europa degli affari e degli stati nazionali nell’Europa dei popoli e della solidarietà, come summa dei valori della modernità;
- l’accoglienza dell’Altro che superi razzismo e pietismo per diventare conoscenza, confronto e scambio paritario nella convivenza planetaria postmoderna.
Redonner de la force aux paysans
I contadini sono stati in questi ultimi 50 anni le maggiori vittime della modernità. Hanno visto sconvolto il loro mondo, spazzati via quei saperi che si tramandavano di generazione in generazione, polverizzata la loro tradizionale socialità. Sono stati cavie della sperimentazione chimica pagando un prezzo altissimo di vite e di malattie professionali per salvare i propri raccolti da parassiti sempre nuovi e di dubbia provenienza. Come se non bastasse hanno dovuto subire – in seguito alla crescita della coscienza ambientale – la demonizzazione degli ambientalisti di città che li hanno accusati di essere i responsabili dell’avvelenamento delle campagne. Il movimento neorurale nato negli anni 1970 è partito da questo presupposto per rilanciare l’agricoltura: i contadini non devono essere gli avvelenatori, innanzitutto di se stessi, ma i custodi della terra e della vita. Quindi ritorno al biologico (che non è una loro invenzione, ma fino agli anni ’50 è stato la norma in campagna), riqualificazione delle colture storiche e recupero del ruolo sociale. Non è stato facile per questi innovatori (tornare indietro per andare avanti!) dialogare con i contadini tradizionali per difficoltà di comunicazione da una parte e dall’altra: gli uni davano per scontate cose che il mondo rurale storico aveva dimenticato, avviluppato com’era nei meccanismi della produzione paraindustriale, gli altri non riuscivano ad accettare il fatto che qualcuno pretendesse di fare il gesto dei padri senza nessuna tradizione alle spalle. Inoltre il sostegno istituzionale di tipo assistenziale legava i contadini a pratiche fasulle (si pensi alle colture di girasole a perdere) che disapprovavano nell’intimo, ma accettavano, talora anche in modo clientelare, come comoda integrazione al reddito magro delle campagne.
Di fatto, l’assenza di una politica culturale che rifondasse l’economia agricola in senso qualitativo ha portato alla sparizione di centinaia di migliaia di piccole e medie aziende negli ultimi due decenni sia per l’assenza di ricambio generazionale sia per l’impossibilità economica di reggere il confronto con le grandi produzioni industriali dei ricostituiti latifondi (l’8% dei proprietari possiede il 63% delle terre coltivabili).
Se, dunque, oggi si vuole fermare questa sorta di genocidio e far sì che l’agricoltura e i contadini contino per davvero, occorre creare una rete di aziende dal basso, che funzioni in senso mutualistico salvaguardando le specificità individuali e sia in grado di proporre un modello di comunità indipendente dalle scelte di finanziamento istituzionale: un nuovo tessuto contadino capace di rivendicare e di interpretare con consapevolezza un ruolo centrale nella vita economica e sociale di un paese. E per fare questo non servono comparse attoriali in documentari di circostanza, testimonial di ricerche antropologiche fini a se stesse, ma un’intesa comune dalle Alpi alla Sicilia per far uscire la campagna dalla subalternità che contraddistingue la sua storia. Dialogo, organizzazione leggera, ma efficace, riconoscimento sociale, con la fiera consapevolezza di essere l’unico “centro di gravità permanente” per qualsiasi ipotesi di un paese futuro.
Di fatto, l’assenza di una politica culturale che rifondasse l’economia agricola in senso qualitativo ha portato alla sparizione di centinaia di migliaia di piccole e medie aziende negli ultimi due decenni sia per l’assenza di ricambio generazionale sia per l’impossibilità economica di reggere il confronto con le grandi produzioni industriali dei ricostituiti latifondi (l’8% dei proprietari possiede il 63% delle terre coltivabili).
Se, dunque, oggi si vuole fermare questa sorta di genocidio e far sì che l’agricoltura e i contadini contino per davvero, occorre creare una rete di aziende dal basso, che funzioni in senso mutualistico salvaguardando le specificità individuali e sia in grado di proporre un modello di comunità indipendente dalle scelte di finanziamento istituzionale: un nuovo tessuto contadino capace di rivendicare e di interpretare con consapevolezza un ruolo centrale nella vita economica e sociale di un paese. E per fare questo non servono comparse attoriali in documentari di circostanza, testimonial di ricerche antropologiche fini a se stesse, ma un’intesa comune dalle Alpi alla Sicilia per far uscire la campagna dalla subalternità che contraddistingue la sua storia. Dialogo, organizzazione leggera, ma efficace, riconoscimento sociale, con la fiera consapevolezza di essere l’unico “centro di gravità permanente” per qualsiasi ipotesi di un paese futuro.
...et aux artisans
Ma quel che vale per i contadini, vale anche per gli artigiani. Una ricerca della Cgia di Mestre su quale impatto abbia avuto la crisi economica sul settore ha rilevato che dal 2009 alla fine del 2014 sono state 94.400 le imprese artigiane che hanno chiuso i battenti. E i bollettini della stessa organizzazione sindacale continuano a riportare periodicamente ulteriori dati negativi, di pari passo con la costante pauperizzazione del paese che ha ridotto drasticamente la domanda interna che è il principale riferimento di mercato delle aziende artigiane.
C’è da dire che anche negli artigiani, come nei contadini, è avvenuto negli ultimi decenni del secolo scorso un mutamento antropologico che ha privilegiato la quantità e la produttività a discapito della qualità e dei saperi tradizionali. In pratica molti di loro, nell’epoca di espansione del mercato del lavoro, si sono trasformati in assemblatori di componenti prodotti da altri e in operatori di macchine di stampo industriale per l’utilizzo delle quali la professionalità e il mestiere tradizionali non erano assolutamente necessari. Ma non c’è stato solo questo: gli artigiani sono stati nei secoli sempre all’avanguardia nella difesa della libertà individuale e sono stati protagonisti, a partire dalla rivoluzione industriale fino alla prima metà del XX° secolo, delle lotte per l’emancipazione e la giustizia sociale. Lavoratori solidali, pronti a sostenere le cause dei più deboli riconoscendole come proprie.
Poi, soprattutto a partire dagli anni 1980, la progressiva spirale di individualizzazione che li ha portati a inseguire il mercato e a dimenticare le loro radici in inebrianti, ma infide avventure imprenditoriali. Pochi sono riusciti a concretizzare le loro nuove aspirazioni, molti sono stati disillusi e hanno pagato o stanno pagando il prezzo della crisi. E chi ancora resiste si trova ad arrancare con contadini e operai ed è costretto a condividere lo stesso destino di precarietà, di quella sorta di “neo-glebalizzazione” che è il mercato globale.
Se anche gli artigiani, come i contadini, vogliono sottrarsi a questa nuova subalternità, se vogliono essere ancora soggetti sociali protagonisti di comunità indipendenti, devono riscoprire le radici professionali e culturali del loro lavoro e, soprattutto, quella pratica della solidarietà che li ha resi a lungo punti di riferimento essenziali nelle lotte di emancipazione civile e sociale.
C’è da dire che anche negli artigiani, come nei contadini, è avvenuto negli ultimi decenni del secolo scorso un mutamento antropologico che ha privilegiato la quantità e la produttività a discapito della qualità e dei saperi tradizionali. In pratica molti di loro, nell’epoca di espansione del mercato del lavoro, si sono trasformati in assemblatori di componenti prodotti da altri e in operatori di macchine di stampo industriale per l’utilizzo delle quali la professionalità e il mestiere tradizionali non erano assolutamente necessari. Ma non c’è stato solo questo: gli artigiani sono stati nei secoli sempre all’avanguardia nella difesa della libertà individuale e sono stati protagonisti, a partire dalla rivoluzione industriale fino alla prima metà del XX° secolo, delle lotte per l’emancipazione e la giustizia sociale. Lavoratori solidali, pronti a sostenere le cause dei più deboli riconoscendole come proprie.
Poi, soprattutto a partire dagli anni 1980, la progressiva spirale di individualizzazione che li ha portati a inseguire il mercato e a dimenticare le loro radici in inebrianti, ma infide avventure imprenditoriali. Pochi sono riusciti a concretizzare le loro nuove aspirazioni, molti sono stati disillusi e hanno pagato o stanno pagando il prezzo della crisi. E chi ancora resiste si trova ad arrancare con contadini e operai ed è costretto a condividere lo stesso destino di precarietà, di quella sorta di “neo-glebalizzazione” che è il mercato globale.
Se anche gli artigiani, come i contadini, vogliono sottrarsi a questa nuova subalternità, se vogliono essere ancora soggetti sociali protagonisti di comunità indipendenti, devono riscoprire le radici professionali e culturali del loro lavoro e, soprattutto, quella pratica della solidarietà che li ha resi a lungo punti di riferimento essenziali nelle lotte di emancipazione civile e sociale.
La révision des instances européennes vers un modèle fédéral
Ma l’indipendenza delle comunità minoritarie territoriali dei vari paesi europei non può prescindere da una revisione profonda delle Istituzioni dell’Unione Europea, che la trasformi in un vero e proprio Stato Federale. Soltanto con una vera sovranità centrale dell’Europa è possibile pensare a processi di indipendenza locale pacifici e costruttivi. Del resto non è possibile liquidare queste istanze come rigurgiti anacronistici di micro nazionalismo, ma bisogna innanzitutto analizzare come sono nate storicamente le varie nazioni europee per rendersi conto che in genere è avvenuto con atti di arbitrio che non hanno tenuto conto delle volontà dei vari popoli. Confini tracciati in seguito a vittorie o sconfitte hanno spesso diviso popoli che vantavano storie di unità millenarie, integrando forzatamente culture e tradizioni diverse con processi autoritari di omologazione. Sono state negate lingue, costumi, usanze, cercando di sovrapporre, come diceva Pasolini, “maschere” alla multiculturalità dei popoli.
Con l’approdo alla democrazia, i vari stati hanno cercato di risolvere il problema delle minoranze con diversi approcci, in genere legati alla loro Storia e alla loro nascita come nazioni, chi con intransigente centralismo (ad esempio la Francia), chi con il riconoscimento di forme di autonomia spesso più identitarie, proprio perché minoritarie, di una vera e propria indipendenza (ad esempio l’Italia). In un caso e nell’altro, però, il dialogo tra culture non è comunque avvenuto, talora appunto per l’intransigenza della cultura dominante, altre per il rancore revanscistico delle culture minoritarie. Perdura, pertanto, una diffidenza reciproca tra maggioranze e minoranze, all’insegna di criteri identitari nazionali e culturali che ormai, nell’epoca della globalizzazione omologante, rischiano di essere concetti vuoti, pure e semplici manifestazioni di nostalgie folcloriche. Perché il nodo sta qui: se un popolo ha completamente dimenticato nei fatti la sua Storia, se ha rinnegato le sue radici agro-pastorali e comunitarie, se partecipa come la maggioranza al rito quotidiano del consumo, se accetta le dinamiche della globalizzazione economico-finanziaria consapevole che queste cancelleranno la particolarità della sua storia e del suo immaginario, che senso ha scendere in piazza o votare in un referendum per l’indipendenza quando questa è ormai il feticcio di quella veramente perduta ?
Ecco dunque che l’azione legislativa di un’ eventuale Confederazione Europea potrebbe garantire alle minoranze piena autonomia e favorire la riunificazione sotto la sua egida di popolazioni da decenni o addirittura da secoli forzatamente divise, magari con la creazione di macro regioni transnazionali che godano di doppia giurisdizione: autonome come cultura, lingua e tradizioni; condivise, e quindi doppiamente tutelate, sul piano politico istituzionale. Ma ciò che anche un governo centrale europeo non potrebbe mai garantire, a meno di un’impensabile revisione della cultura tecnocratico-industriale delle sue élites, è il modo in cui queste comunità vivranno la loro autonomia; questo dipenderà solo dalla loro scelta: continuare a inseguire il mito dello sviluppo illimitato o abbracciare seriamente un nuovo modello di sviluppo che sia compatibile con l’ambiente e recuperi i loro saperi tradizionali riproponendoli in chiave moderna e aggiornata? Nessuno, a quel punto, potrà vantare alibi e nascondersi dietro il fatto che, forse, è impossibile cambiare in quanto ci siamo spinti troppo in là e siamo ormai avviluppati in un sistema che ci vede necessariamente conniventi. Cambiare si può, a cominciare dalla lingua minoritaria, che deve diventare prima lingua sia nella scuola sia nell’uso quotidiano; ma dobbiamo essere convinti di questo e non dirlo soltanto per sentimento e poi magari non parlarla con i propri figli. Perché è questa la vera minorità, la paura di sentirsi in questo modo minoritari.
Con l’approdo alla democrazia, i vari stati hanno cercato di risolvere il problema delle minoranze con diversi approcci, in genere legati alla loro Storia e alla loro nascita come nazioni, chi con intransigente centralismo (ad esempio la Francia), chi con il riconoscimento di forme di autonomia spesso più identitarie, proprio perché minoritarie, di una vera e propria indipendenza (ad esempio l’Italia). In un caso e nell’altro, però, il dialogo tra culture non è comunque avvenuto, talora appunto per l’intransigenza della cultura dominante, altre per il rancore revanscistico delle culture minoritarie. Perdura, pertanto, una diffidenza reciproca tra maggioranze e minoranze, all’insegna di criteri identitari nazionali e culturali che ormai, nell’epoca della globalizzazione omologante, rischiano di essere concetti vuoti, pure e semplici manifestazioni di nostalgie folcloriche. Perché il nodo sta qui: se un popolo ha completamente dimenticato nei fatti la sua Storia, se ha rinnegato le sue radici agro-pastorali e comunitarie, se partecipa come la maggioranza al rito quotidiano del consumo, se accetta le dinamiche della globalizzazione economico-finanziaria consapevole che queste cancelleranno la particolarità della sua storia e del suo immaginario, che senso ha scendere in piazza o votare in un referendum per l’indipendenza quando questa è ormai il feticcio di quella veramente perduta ?
Ecco dunque che l’azione legislativa di un’ eventuale Confederazione Europea potrebbe garantire alle minoranze piena autonomia e favorire la riunificazione sotto la sua egida di popolazioni da decenni o addirittura da secoli forzatamente divise, magari con la creazione di macro regioni transnazionali che godano di doppia giurisdizione: autonome come cultura, lingua e tradizioni; condivise, e quindi doppiamente tutelate, sul piano politico istituzionale. Ma ciò che anche un governo centrale europeo non potrebbe mai garantire, a meno di un’impensabile revisione della cultura tecnocratico-industriale delle sue élites, è il modo in cui queste comunità vivranno la loro autonomia; questo dipenderà solo dalla loro scelta: continuare a inseguire il mito dello sviluppo illimitato o abbracciare seriamente un nuovo modello di sviluppo che sia compatibile con l’ambiente e recuperi i loro saperi tradizionali riproponendoli in chiave moderna e aggiornata? Nessuno, a quel punto, potrà vantare alibi e nascondersi dietro il fatto che, forse, è impossibile cambiare in quanto ci siamo spinti troppo in là e siamo ormai avviluppati in un sistema che ci vede necessariamente conniventi. Cambiare si può, a cominciare dalla lingua minoritaria, che deve diventare prima lingua sia nella scuola sia nell’uso quotidiano; ma dobbiamo essere convinti di questo e non dirlo soltanto per sentimento e poi magari non parlarla con i propri figli. Perché è questa la vera minorità, la paura di sentirsi in questo modo minoritari.
Le rapport à l’Autre
C’è infine il problema dell’accoglienza dell’Altro, che sta suscitando in tutti i paesi europei rigurgiti xenofobi che ci rimandano tristemente al passato. Eppure è un problema che, volenti o nolenti, ci coinvolgerà per parecchi anni a venire fino a quando non riusciremo a stabilire relazioni paritarie con gli altri continenti applicando concretamente la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino su scala planetaria.
Per capire l’ineluttabilità dell’invasione non si può prescindere dalla conoscenza delle ragioni per cui moltitudini sempre più consistenti di esseri umani stanno fuggendo dai loro paesi. In un modo o nell’altro sono tutte legate al nostro approccio di occidentali a quei mondi, fatto di depredazione di risorse, di autoritarismo coloniale e di disprezzo razziale. Ma soprattutto di processi coatti di deculturazione e di acculturazione per trasformare anche quelle popolazioni in reali o potenziali consumatori. E sono ragioni talmente oggettive e lampanti che nessuno se la sente di negarle e allora preferisce non prenderle in considerazione e assumere un atteggiamento di rifiuto irrazionale: “Non mi interessa perché vengono quì, io non ce li voglio”. Poi, magari, quei politici che su queste posizioni prerazzistiche costruiscono le loro fortune le rimpinguano con dichiarazioni di difesa dei valori cristiani (!) e occidentali, cercando di mascherare le loro miopie politiche e culturali con qualcosa in cui non credono, nei fatti, nemmeno più loro. E tra la gente si diffonde la paura, che diventa l’unica forma di coagulo di una società che, come diceva Bauman, è sempre più “liquida” e atomizzata.
Ma anche quando gli Stati sono disponibili all’accoglienza, essa si manifesta concretamente con forme di detenzione in campi “lager” in perpetua attesa di ciò che non avverrà mai, l’integrazione nella realtà civile, sociale ed economica dei luoghi. Strutture gestite spesso da gente senza scrupoli che ha fatto dell’immigrazione un affare: il modo migliore per creare eserciti di disadattati che diventano facile preda del crimine e del fanatismo.
È da questa impostazione ipocrita e controproducente che deve dissociarsi l’atteggiamento di accoglienza delle comunità libere e indipendenti: esse, forti delle loro identità ritrovate, devono impostare con i migranti un dialogo tra persone di pari dignità, che tenga conto costantemente del diritto fondamentale di ogni uomo a una vita degna di essere vissuta. Diritto che non può prescindere dal lavoro che, oltre a essere fonte di sostentamento, è il terreno migliore di confronto. Loro come portatori di culture antiche e di saperi che da noi sono andati perduti, noi come figli di un mondo che ha esaurito la sua spinta economica e sociale e non riesce ancora a raccapezzarsene. Dall’integrazione di queste due diversità può nascere quell’atteggiamento di recupero del passato come “memoria attiva” che è il volano indispensabile per un modello di sviluppo a misura d’uomo e a basso impatto ambientale, l’unico che può ancora garantire alle popolazioni europee e degli altri continenti di avere un futuro sulla Terra e di ritrovare il senso più autentico e solidale della convivenza umana.
Per capire l’ineluttabilità dell’invasione non si può prescindere dalla conoscenza delle ragioni per cui moltitudini sempre più consistenti di esseri umani stanno fuggendo dai loro paesi. In un modo o nell’altro sono tutte legate al nostro approccio di occidentali a quei mondi, fatto di depredazione di risorse, di autoritarismo coloniale e di disprezzo razziale. Ma soprattutto di processi coatti di deculturazione e di acculturazione per trasformare anche quelle popolazioni in reali o potenziali consumatori. E sono ragioni talmente oggettive e lampanti che nessuno se la sente di negarle e allora preferisce non prenderle in considerazione e assumere un atteggiamento di rifiuto irrazionale: “Non mi interessa perché vengono quì, io non ce li voglio”. Poi, magari, quei politici che su queste posizioni prerazzistiche costruiscono le loro fortune le rimpinguano con dichiarazioni di difesa dei valori cristiani (!) e occidentali, cercando di mascherare le loro miopie politiche e culturali con qualcosa in cui non credono, nei fatti, nemmeno più loro. E tra la gente si diffonde la paura, che diventa l’unica forma di coagulo di una società che, come diceva Bauman, è sempre più “liquida” e atomizzata.
Ma anche quando gli Stati sono disponibili all’accoglienza, essa si manifesta concretamente con forme di detenzione in campi “lager” in perpetua attesa di ciò che non avverrà mai, l’integrazione nella realtà civile, sociale ed economica dei luoghi. Strutture gestite spesso da gente senza scrupoli che ha fatto dell’immigrazione un affare: il modo migliore per creare eserciti di disadattati che diventano facile preda del crimine e del fanatismo.
È da questa impostazione ipocrita e controproducente che deve dissociarsi l’atteggiamento di accoglienza delle comunità libere e indipendenti: esse, forti delle loro identità ritrovate, devono impostare con i migranti un dialogo tra persone di pari dignità, che tenga conto costantemente del diritto fondamentale di ogni uomo a una vita degna di essere vissuta. Diritto che non può prescindere dal lavoro che, oltre a essere fonte di sostentamento, è il terreno migliore di confronto. Loro come portatori di culture antiche e di saperi che da noi sono andati perduti, noi come figli di un mondo che ha esaurito la sua spinta economica e sociale e non riesce ancora a raccapezzarsene. Dall’integrazione di queste due diversità può nascere quell’atteggiamento di recupero del passato come “memoria attiva” che è il volano indispensabile per un modello di sviluppo a misura d’uomo e a basso impatto ambientale, l’unico che può ancora garantire alle popolazioni europee e degli altri continenti di avere un futuro sulla Terra e di ritrovare il senso più autentico e solidale della convivenza umana.